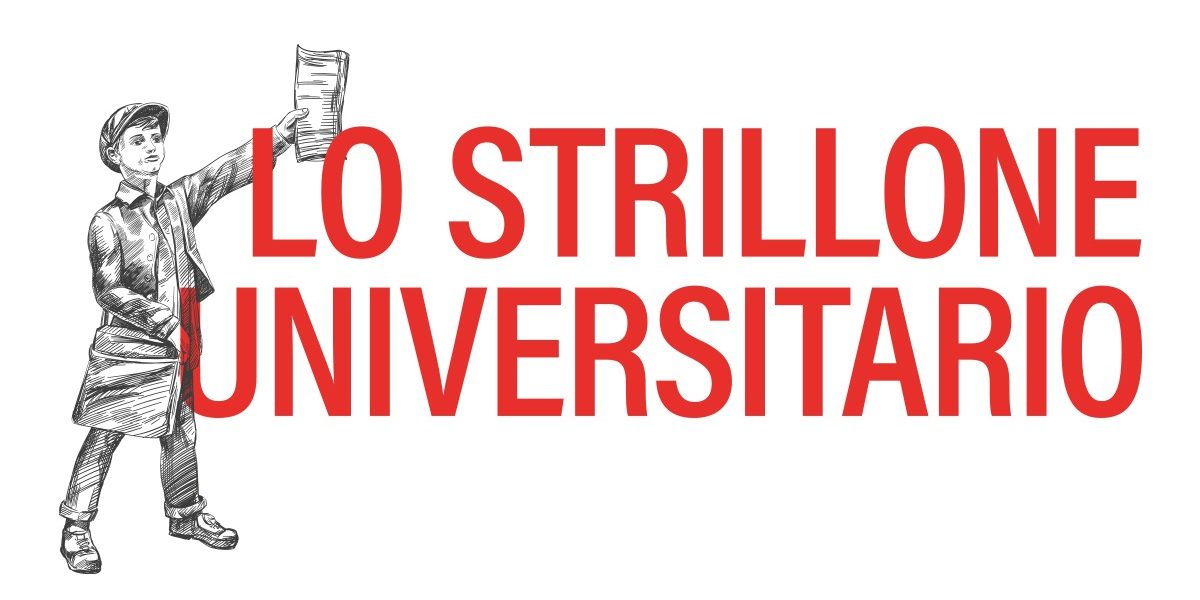La riflessione che ci apprestiamo a fare nasce da un fenomeno molto diffuso nella nostra società e pressoché radicato nella vita di ognuno di noi. Nonostante, infatti, ciascuno nasce e cresce in condizioni diverse che lo accompagnano in un percorso singolare di percezione dell’essere e del vivere, tutti ci dimostriamo carnefici solidali in un univoco comportamento che ci colpisce più di
quanto pensiamo.
L’uomo lungo tutto il suo percorso di vita è continuamente messo di fronte ad ostacoli, ad incertezze che inevitabilmente lo obbligano a fare i conti col proprio io e con i propri limiti. Si cerca molto spesso, in un mondo che ormai è diventato esigente e instancabilmente incontentabile, di mostrare il meglio di sé e quindi di far prevalere la parte migliore. Si potenziano le abilità che si hanno, si infiammano quelle potenzialità che sono soltanto scintille e questo di per sé non è mai sbagliato. Sbagliato è, invece, l’atteggiamento che ci porta a scacciare sotto il tappeto la polvere delle nostre debolezze, cercando di evitarle da sguardi estranei indiscreti e poco comprensivi.
Nonostante questo atteggiamento parta dall’analisi della propria persona, finisce inesorabilmente per essere espanso anche agli altri, ma in senso opposto. Quando qualcuno si spinge oltre le convinzioni che padroneggiano la mente degli altri proprio perché spera di poter vincere contro quei suoi limiti, qualcun altro, dall’altra parte della strada, monitora la situazione con aria di scetticismo.
Forse per eredità verghiana tutti tendiamo a pensare che chi si spinge un po’ più in alto per raggiungere una posizione tra gli dei dell’Olimpo, dovrà far i conti con la sconfitta. E dopo aver constatato con convinzione ciò, ci apprestiamo con atteggiamento spicciativo a catalogare l’altro tra i vinti o tra i minchioni che non avrebbero mai dovuto neanche sognare l’impresa.
Julio Velasco, dirigente sportivo e allenatore di pallavolo argentino, nella sua “Teoria degli alibi” esprime un concetto che in questo discorso è la chiave di volta. Così come nel volley, anche nella vita se la squadra perde la colpa è primariamente attribuita allo schiacciatore che guarda l’alzatore male per non avergli passato una buona palla. L’alzatore, dal canto suo, per alleviare il peso del rimprovero che pende sul suo capo, si rivolgerà con aria di condanna verso i suoi compagni in ricezione che, non avendo altri verso cui posare lo sguardo, guarderanno il soffitto assicurandosi che l’impianto d’illuminazione non abbia qualche problema che gli ostruisca la visuale. In conclusione, si è perso per colpa dell’elettricista. Dentro questo semplice quadro, si muove in sottofondo il concetto che Primo Levi espresse nel suo libro “La tregua”. Citando testualmente: “In ogni gruppo umano esiste una vittima predestinata: uno che porta pena, che tutti deridono, su cui nascono dicerie insulse e malevole, su cui con misteriosa concordia, tutti scaricano i loro mali umori e il loro desiderio di nuocere”. Se non fosse che, nel caso di Velasco, la vittima predestinata è ognuno di noi che di volta in volta, a seconda della prospettiva di chi guarda, diventa non solo vittima, ma individuo desideroso di ricercare il colpevole al di fuori di se stesso. E inizia il classico processo dello scarica barile, secondo cui ognuno cerca di giustificarsi puntando il dito su quello che dovrebbe essere un suo compagno, cioè su colui che, in fondo, desiderava lo stesso epilogo. Ed in questo atteggiamento vile dell’uomo si evince il comune istinto dell’umano a ricercare giustificazioni al suo “non fare” per celare la sua innata indole ad essere predominante, governatore. Non si riconosce nessun errore personale e quindi nessuna bellezza nella mancata perfezione, che continuerà appunto a rimanere tronca, priva di un pezzo quindi mancante. Perché sarebbe pregiudizievole della propria grandezza dichiarare di aver sbagliato, di essere stato sotto le aspettative. Sarebbe come ammettere di non essere all’altezza. Quindi si preferisce aspirare a diventare eroi, anziché semplici uomini che ragionano sui loro errori, che lottano per battere i loro limiti. E questi ultimi non possono che essere personali, individuali. Batterli significa non solo vivere nella consapevolezza di essere soggetti indotti a sbagliare per natura, ma anche persone che nell’errore si riconoscono più che nella riuscita dell’impresa. Diventare dei, dunque, ha poco significato se non sai che le tue paure ti identificano, se non sai che le battaglie più grandi le combatti con te stesso e non su un campo da gioco.
Secondo Velasco, è necessario dunque cambiare la mentalità troppo fossilizzata a guardare cosa fa l’altro, a cercare l’incertezza nel movimento altrui che è poi l’elemento soggetto a giudizio. Scavare nei proprio errori significa conoscersi e vinceranno tutti coloro che sapranno mettere da parte l’orgoglio per mostrarsi umili, nudi. E quando questa prospettiva si realizzerà non esisteranno più schieramenti, né vincitori e né vinti, ma solo uomini che nel dinamismo del gioco e quindi della vita esistono, imparano e crescono.
Maria Sola