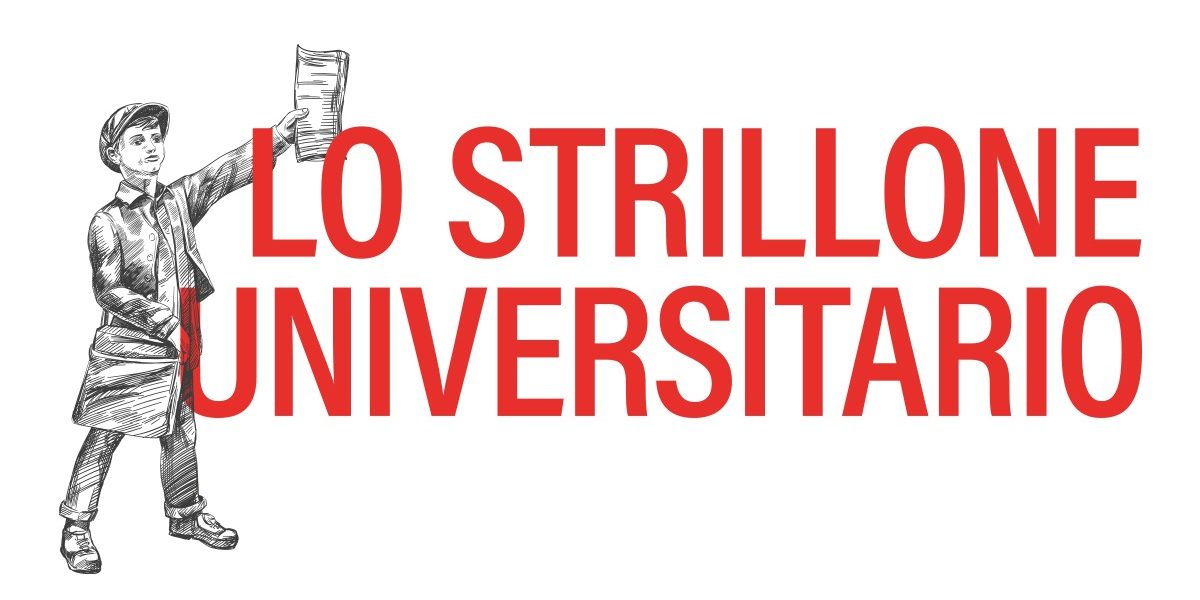Nella sua evoluzione, la cinematografia è passata dalla documentazione del quotidiano all’evocazione delle più forti sensazioni nel pubblico, che al termine della proiezione possono essere tranquillamente lasciate nella dimensione dove hanno avuto origine, come capi d’abbigliamento abbandonati in un camerino dopo essere stati frettolosamente provati. Al termine del breve documentario “Baladì – This Is My Village” di Cristiano Regina questo privilegio non viene concesso, sebbene il contenuto dei 37 minuti di riprese sia quanto di più distante ci sia dagli standard di impatto emotivo diretto ai quali siamo stati gradualmente assuefatti dalla cinematografia odierna basata su effetti speciali e ardite tecniche di registrazione. Anzi, al contrario, le riprese si svolgono tendenzialmente in pieno giorno alla luce del sole, nel caldo che costringe alcuni ragazzi a cercare refrigerio in una vasca di cemento improvvisatasi piscina, con un ritmo rilassato che ben si sposa con l’ambientazione pressoché rurale e la totale assenza di colonna sonora, in un calmo susseguirsi di racconti da parte degli abitanti del piccolo villaggio palestinese di Wadi Fukin. Ma forse è proprio questa calma a dare una carica emotiva estremamente intensa ai dialoghi pregni di sofferenza vissuta riportati in “Baladì”, capaci di provocare prima – e far perdurare poi – un forte senso di scoramento misto ad impotenza ben oltre lo spegnimento delle luci in sala, aleggiando a lungo assieme alle numerose domande senza risposta che il film solleva nello spettatore. Le riprese e la loro gestione sono state affidate agli stessi abitanti del villaggio dopo essere stati adeguatamente istruiti su come maneggiare l’attrezzatura cinematografica portata in loco dai volontari dell’Organizzazione italiana “Overseas” durante il loro breve soggiorno, e le inquadrature dei novelli cineasti non si dilungano in tecnicismi o sperimentazione, bensì sono spesso statiche, mettendo al centro dell’inquadratura non cosa accade, quanto la fitta trama di racconti che anima il paese e ne costituisce lo spirito più vibrante. Le scene si snodano tra gli edifici semi distrutti e parzialmente ricostruiti del paese, cicatrici memori di infelici momenti vissuti fortunatamente solo da pochi degli attuali cittadini, concentrandosi sui suoi abitanti, linfa vitale di un lembo di terra palestinese di poco meno di 3 chilometri quadrati sul fondo di una vallata sovrastata dal confine con lo Stato di Israele da un lato e dalle sue colonie dall’altro. Sebbene non sia immediatamente percepibile come tale, viene presto compreso come Wadi Fukin viva e perseveri nonostante la silenziosa e statica morsa esterna su “tutti e 6 i suoi lati” che non accenna a scemare sin dal 1972, quando dopo 24 anni di esilio forzato gli abitanti del villaggio furono autorizzati a poter tornare nuovamente alla loro terra dalla quale erano stati scacciati militarmente nel 1948. L’essersi visti concedere un mese per rimediare ai danni causati dall’incuria e dai vicini oltreconfine portò i rimpatriati, secondo la locale leggenda, a ricostruire il villaggio in una sola notte, dando ulteriore prova della tenacia che gli abitanti di Wadi Fukin hanno portato avanti sin dal loro insediamento nella vallata. La tacita minaccia di attacco fa perdurare un continuo stato di impotenza, che rasenta una forma di disperazione profonda ma ben lontana dalle lacrime che ci si potrebbe aspettare di primo acchito da chi si trovi in una situazione così delicata: non esistono certezze per chi non sa se quella terra potrà ancora portare il suo nome il giorno successivo, mentre i confini artificiosamente costruitele attorno non accennano a smettere di ridursi, in un’opera che giorno dopo giorno vede la vallata sempre più minacciata dalla progressiva discesa di una colonia di più di quarantamila persone, d’innanzi a cui poco possono fare il migliaio di palestinesi insediati nel villaggio; la crescita della colonia rimane infatti un processo lento, costante, snervante ma soprattutto inarrestabile. Questa visione disincantata e drammatica nella sua quotidianità viene riportata fedelmente e nel modo quanto più imparziale possibile dalla telecamera, che inquadra gli evidenti contrasti della piccola enclave palestinese dove bambini a bordo di hoverboard condividono la piazza con anziani pastori e le loro greggi, e dove l’argine alla scomparsa del paese pare essere rappresentato dalla resistenza dei suoi cittadini misurabile nella stoica cura riposta nell’agricoltura e nell’allevamento che da sempre hanno rappresentato un cardine fondamentale per gli abitanti, persino durante l’esilio forzato di 24 anni durante i quali alba e tramonto rappresentavano gli unici momenti in cui poter tentare di mantenere vive le coltivazioni di quelle terre mettendo a rischio la propria vita nella speranza di un domani migliore che in fondo non si è mai davvero avverato, nonostante il tanto sperato rientro al punto di origine. E nonostante il fosco passato ed il non certo radioso futuro, le scorribande dei confinanti ed il persistente sentimento di insicurezza, la speranza sembra non lasciare mai davvero i paesani: c’è ancora chi ritiene possibile la cessazione delle ostilità ed una pacifica coabitazione tra le due Nazioni che permetta ad entrambe di appianare le divergenze che per decenni hanno fornito combustibile alle più violente azioni, e di permettere così a Wadi Fukin di cessare di limitarsi a sopravvivere per rinascere davvero una volta per tutte. Sebbene sembri uno scenario ancora distante dal suo concepimento e dalla sua completa realizzazione, lo sguardo degli intervistati sembra non permettere di considerare accettabile un’alternativa al villaggio, valutazioni comunque già accuratamente dissezionate da chi nel corso degli anni ha visto i propri parenti fuggire o cadere sotto i proiettili dell’esercito nell’evacuazione forzata del 1948. Questa stoica fermezza si mostra come il collante, l’anima del documentario stesso, durante il quale non si stanno semplicemente intervistando persone che abitano a Wadi Fukin, quanto interrogando la sua anima. Wadi Fukin è più di un semplice appezzamento su un documento catastale e non può esistere senza i suoi abitanti, ed i cittadini di Wadi Fukin dimostrano in risposta questo legame simbiotico di testardo attaccamento per la terra che ha dato loro i natali, la radice della propria esistenza in quanto comunità, senza la quale la loro identità non potrebbe definirsi veramente completa.
Giacomo Rippa