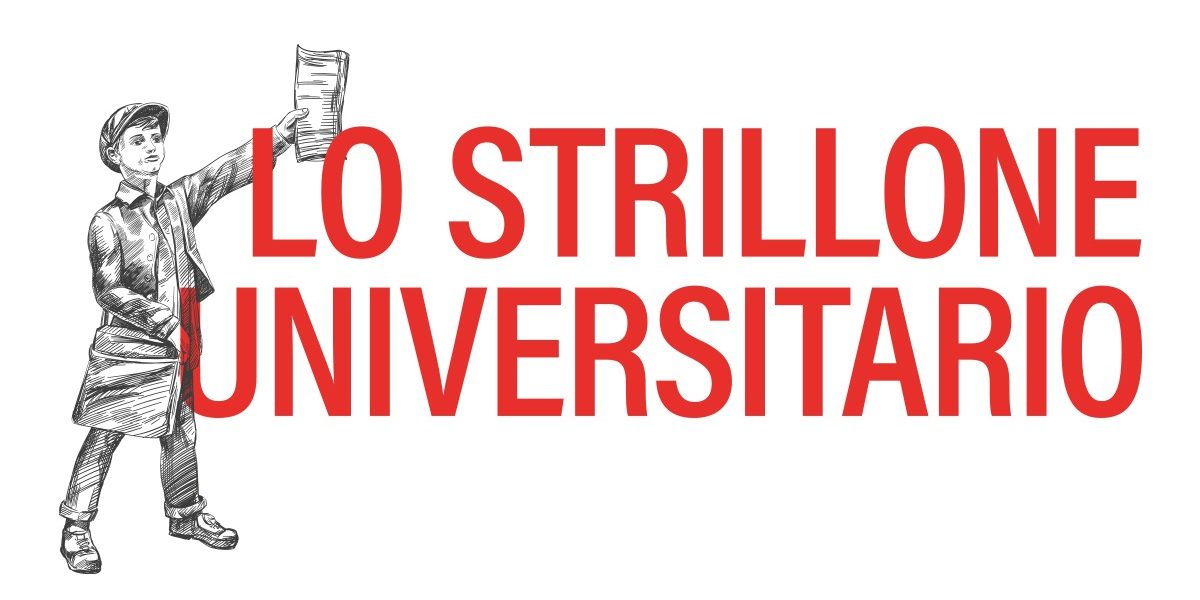(Recensione del libro “La nazione delle piante” di Stefano Mancuso)

La taglia ridotta di “La nazione delle piante” di Stefano Mancuso non ne farebbe sospettare il prezioso contenuto: in nemmeno centocinquanta pagine l’autore riesce a concentrare, comunicandola in maniera limpida e diretta, una quantità di scienza che illumina e sorprende. D’altra parte Mancuso accompagna all’esperienza pluridecennale di studioso anche quella di divulgatore di successo, sia in Italia che all’estero. Questo suo piccolo libro possiede una capacità sproporzionata di ampliare gli orizzonti di chi lo legge, completandoli di elementi essenziali di cui non si era neppure concettualizzata l’assenza.
La premessa fantastica, l’artificio retorico di partenza è che le piante, compagne ed oggetto di studio dell’autore da tanti anni, abbiano deciso di dettargli la loro Costituzione, quale dono e monito per la specie umana. Mancuso dunque presta volentieri la propria penna all’evangelizzazione verde, trascrivendo un corpus di 8 articoli che esprimono i principi generali sui quali si basa la vita delle piante. La prosopopea funge da pretesto per quello che è chiaramente un esercizio giocoso: l’obiettivo non è certo quello di argomentare filosoficamente in favore di un giusnaturalismo vegetale (non seriamente, almeno). Eppure questa Costituzione delle piante non di rado sfocia in proposte, in realtà più politiche che giuridiche, nient’affatto scherzose. Inoltre La nazione delle piante si rivela particolarmente interessante per chi studia o ha a che fare con il diritto, non perché si tratti di un’opera giuridica (l’autore si dichiara felicemente estraneo al genere), ma perché esprime in sostanza la prospettiva di uno scienziato che, fatti e dati alla mano, li tende con urgenza verso il mondo del diritto e, più in generale, la società, chiedendo e sperando di esserne ascoltato.
Mentre l’antropocentrismo delle nostre costituzioni riduce a cose, res, tutto quanto non sia umano (piante incluse), il soggetto della Costituzione vegetale è la comunità dei viventi complessivamente intesa.
L’articolo 1 della Costituzione vegetale attribuisce la sovranità sulla Terra a tutti gli esseri viventi, non ad una sola specie. Tuttavia pare che l’uomo sia l’unico sulla Terra a non conformarsi a questo atto di portata generale, ragion per cui Mancuso si impegna ad esplicitarla nero su bianco, adattandola alle categorie umane perché noi possiamo comprenderla e identificarci come suoi destinatari. Un esempio di questa accorta intermediazione è già nel titolo: si parla di Nazione, non di Regno, per meglio rispecchiare l’organizzazione delle piante che coesistono e prosperano sul pianeta in un regime di avanzatissima democrazia decentralizzata.
La Costituzione delle piante non si sostituisce a quelle umane come stravagante alternativa o curioso spostamento di focus: si impone a tutti i viventi perché si tratta di principi che rendono possibile la vita stessa sulla Terra, per il semplice motivo che è grazie alle piante che questa vita è possibile.
Mancuso tuttavia affronta il problema della loro legittimazione anche in termini più spiccatamente umani. Se si tenessero delle elezioni democratiche fra tutti gli esseri che abitano la Terra, chi le vincerebbe? Le piante rappresentano l’80% della biomassa del pianeta, mentre l’uomo un misero 0,01%. Non passeremmo neanche la soglia di sbarramento.
Proviamo allora con l’opzione aristocratica: non è forse l’uomo migliore di un pruno, di un riccio, di una felce? La specie migliore, però, non può che essere quella più longeva, in quanto l’obiettivo principale comune ad ogni specie è la sopravvivenza. La durata media della vita di una specie sulla Terra è di 5 milioni di anni. Si hanno prove della comparsa di homo sapiens risalenti a un massimo di 300mila anni fa; questo di per sé non soffocherebbe ogni nostra velleità aristocratica, non fosse che pochi umani oggigiorno scommetterebbero che la razza umana sopravvivrà a se stessa anche solo altri mille, cento anni.
Gli otto articoli della Costituzione vegetale sono abbastanza vari per forma e contenuto. I primi quattro fanno eco ai loro corrispettivi nella Costituzione italiana (ad esempio l’art. 2 che, prevedendo l’intangibilità delle comunità naturali, fa chiaramente il contrappunto al suo omologo nella Carta circa i diritti inviolabili dell’uomo).
Mentre la maggioranza degli articoli è formulata nella veste di diritti soggettivi, all’art. 6 invece troviamo un divieto assoluto e inderogabile: “Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato”. L’annessa spiegazione di Mancuso non ammorbidisce affatto questa disposizione, ma la approfondisce, traendone le logiche conseguenze inerenti al nostro modello di sviluppo: “E’ semplicissimo: risorse limitate non possono sostenere una crescita illimitata (…) dei consumi”. La qual cosa sfortunatamente è proprio ciò che si prospetta (e si auspica!) a livello globale. E no, dice Mancuso, la tecnologia non ci salverà: nonostante gli enormi progressi scientifici e tecnici conseguiti, il Rapporto sui limiti dello sviluppo del 1972 (secondo il quale ogni modello di sviluppo basato sulla crescita continua è, inevitabilmente, destinato al collasso) non è stato affatto confutato, anzi: i parametri chiave presi in esame dal Rapporto hanno avuto andamenti reali praticamente sovrapponibili a quelli simulati. A margine di quest’analisi dei limiti del capitalismo, a dire la verità non troppo originale, Mancuso suggerisce che dovremmo invece seguire il modello delle piante, le quali “hanno imparato a convivere con la finitezza delle risorse e a modulare lo sviluppo”, trasformando addirittura la propria anatomia per sopravvivere in tempi di scarsità di risorse. E’ quello che fanno i bonsai, adeguandosi alle condizioni sfavorevoli create artificialmente dall’uomo per indurne la “nanizzazione”. Mancuso rincara: “L’insana idea che sia possibile crescere indefinitamente in un ambiente che dispone di risorse limitate è soltanto umana. Il resto della vita segue modelli realistici”.
La didascalia allegata all’articolo 8 è dedicata al debunking di un luogo comune tanto diffuso quanto scientificamente errato: la credenza che in natura la legge del più forte valga più di ogni altra legge, costituendo un meccanismo attraverso il quale l’evoluzione seleziona “i migliori” mettendoli in competizione fra loro per la sopravvivenza. Quest’idea venne attribuita a Darwin da alcuni dei suoi interpreti più discutibili, i cosiddetti darwinisti sociali. Anche se presenta innegabili vantaggi dal punto di vista della giustificazione di svariate ideologie discriminatorie, la nozione che in natura tutto si basi sulla competizione spietata è un modo piuttosto semplicistico di spiegare le relazioni fra i viventi, che sono in realtà molto più complesse. La “teoria del mutuo appoggio” di Kropotkin, secondo la quale il vero motore dell’evoluzione non è la competizione, ma la capacità degli individui di cooperare, ha trovato conferma nel lavoro della scienziata Lynn Margulis, che nel 1967 con la sua rivoluzionaria teoria endosimbiotica seriale scoprì che simbiosi fra batteri avevano dato origine alle cellule eucariote, ossia alle cellule che costituiscono sia i vegetali che gli animali. Anche nel campo del mutuo appoggio, sottolinea Mancuso, le piante eccellono: forse proprio perché impossibilitate nel movimento si sono evolute puntando al massimo sulla cooperazione con i vicini, vegetali e non.
Le indicazioni e proposte politico-sociali, più o meno esplicite e definite, che Mancuso sembra ricavare dall’esempio virtuoso delle piante in diversi ambiti, non restituiscono un quadro d’azione compiuto e unitario, anzi. Se l’articolo 8 lo porta a tifare per la cooperazione quale “forza attraverso la quale la vita prospera”, il commento all’articolo 3 (il principio di uguaglianza di questa costituzione) conclude contro l’efficacia e la convenienza delle organizzazioni accentrate tipiche delle gerarchie animali, in favore della decentralizzazione tipica degli organismi vegetali. E’ evidente che questi due principi non si conciliano facilmente: è possibile per gli umani cooperare su larga scala senza l’impiego di gerarchie che li organizzino?
Forse la proposta più valida fra quelle avanzate da Mancuso è contenuta nel suo commento all’articolo 5 (“la Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e all’atmosfera puliti”).
Attraverso il miracolo della fotosintesi le piante, anello di congiunzione tra la Terra e il Sole, fissano l’anidride carbonica dell’atmosfera, producendo come materiale di scarto l’ossigeno e formando zuccheri. Quest’energia chimica è utilizzata dal resto della vita animale per sopravvivere; quando questo carburante brucia, produce CO2 che si accumula nell’atmosfera, salvo poi venire nuovamente fissata dalle piante che effettuano la fotosintesi. Questi sono i tratti essenziali del ciclo del carbonio, del quale le piante sono indubbiamente le protagoniste. Ora, l’effetto serra è dovuto proprio allo sfasamento di questo ciclo: in concomitanza con la rivoluzione industriale, la quantità di CO2 immessa nell’atmosfera è diventata così enorme da non poter più essere interamente fissata dalle piante. La concentrazione di diossido di carbonio è salita a livelli tali da determinare quel riscaldamento climatico di cui tanto ci preoccupiamo, senza peraltro avere un’idea chiara di cosa fare per contrastarlo efficacemente.
Una prima possibile soluzione a questo problema è la riduzione delle emissioni, obiettivo perseguito da numerosi accordi internazionali senza però, duole constatarlo, alcun esito apprezzabile: dal 1988 ad oggi, le emissioni globali annue sono aumentate del 40% rispetto all’inizio del processo.
Ma Mancuso pone l’accento sulla seconda via, una soluzione che appare evidente appena illustrate le linee generali del problema: se non riusciamo a diminuire la CO2, aumentiamo le piante! L’entusiasmo con cui lo scienziato propone questa strategia – che non è tanto un’alternativa all’altra, quanto una misura necessaria da cumulare agli sforzi per la decarbonizzazione – è contagioso: “Le nostre città (…) sono anche i luoghi del pianeta responsabili della produzione delle maggiori quantità di CO2. Dovrebbero essere interamente coperte di piante. (…) La regola dovrebbe essere una sola e semplice: dovunque sia possibile far vivere una pianta, deve essercene una.” Accanto a queste parole d’ordine che evocano la verdeggiante e idilliaca estetica solarpunk, Mancuso insiste con altrettanto fervore sulla speculare necessità di “un trattato internazionale” che qualifichi la deforestazione come “crimine contro l’umanità”. E’ forse in questo passo che batte più forte il cuore di questo piccolo, audace libro e del suo autore.
Se fatichiamo a prendere sul serio la proposta di Mancuso di una riforestazione urbana, ciò non fa che provare lo scarto che ci separa culturalmente dalla natura, oltre che la nostra assodata difficoltà a pensare fuori dagli schemi che ci sono familiari. Perché non si tratta affatto della trovata stravagante di uno scienziato preso da una smodata passione per i vegetali: rafforzare la Nazione delle Piante è una delle due principali strategie che la scienza (nonché la logica elementare) mette a nostra disposizione per fermare il surriscaldamento globale e riequilibrare il ciclo del carbonio.
Ma perché il diritto si è sempre mostrato così disinteressato nei confronti dei viventi non umani, così sordo alle loro istanze? Ibi jus, ubi societas, si dice. Il diritto è fenomeno sociale, cosa tipicamente umana. Siamo una specie litigiosa: è più probabile che due umani costretti a vivere l’uno vicino all’altro si citino in giudizio a vicenda prima che fra di loro si instauri rapporto simbiotico simile a quello fra l’alga e il fungo che costituiscono un lichene. Ma in quest’epoca geologica chiamata Antropocene, in cui l’attività umana ha sfregiato e trasfigurato come non mai il volto dell’unico pianeta che ospiti la vita, non sarebbe forse il caso che il diritto allargasse la propria visione alla natura, al di fuori della quale non è possibile la vita e quindi nemmeno la societas stessa? Ibi jus, ubi societas. Sed ubi societas?
Dell’antropocentrismo filosofico che tutt’oggi detta letteralmente legge nelle nostre società potremmo come al solito incolpare la Grecia classica. Infatti l’umanesimo può essere comodamente fatto risalire a Protagora (“L’uomo è la misura di tutte le cose”) e potremmo rintracciare nel Fedro di Platone un esempio illustre quanto lampante di esclusivismo antivegetale (Socrate che afferma: “Il fatto é che a me piace imparare, ma la campagna e gli alberi non vogliono insegnarmi nulla, a differenza degli uomini della città”). Dall’altra parte la figura di Serse, il re persiano che flagellò l’Ellesponto e fu poi baroccamente resuscitato da Haendel per cantare un’aria accorata in onore di un platano, potremmo ben dichiararla sconfitta e soccombente nella seconda guerra persiana come nella competizione per determinare il DNA filosofico dell’occidente.
Nella mitologia greca i dodici Olimpi, l’élite divina che governava le sorti del mondo appollaiata sul famoso Monte, componevano una comitiva spiccatamente antropomorfa, non solo quanto alle sembianze esterne ma anche per la loro anatomia morale. Lungi dall’essere immuni dalle passioni e dai vizi umani, questi dei ancora oggi rappresentano nel nostro immaginario una decisiva apoteosi antropocentrizzante della specie homo sapiens.
Il pantheon ellenico conosceva anche divinità minori più vicine al mondo animale: basti pensare a Pan, incrocio fra uomo e capro, o a creature mitologiche come i centauri.
Ma le piante si trovavano relegate proprio all’infimo gradino della gerarchia mitologica: in particolare le amadriadi (il cui nome significa “coesistenti con gli alberi”) erano ninfe dei boschi le cui vite erano inestricabilmente legate agli alberi che abitavano. Quando la pianta che fungeva da dimora di un’amadriade moriva, la ninfa moriva con lei.
Volendo fare un’interpretazione creativa, o meglio una revisione del mito greco nello spirito della Costituzione delle piante, si potrebbe affermare che tutti gli dei e le dee, in quanto originati dalla fantasia dell’uomo il quale, come s’è visto, non può considerarsi indipendente dalla natura, siano amadriadi. Sono amadriadi de facto tutte le dee, così come le idee che personificano. Persino la Giustizia, divinizzata dai greci come Dike, figlia di Zeus e Temi, non può più fingere di non avere radici che la ancorino a questa Terra: metà del suo sangue è linfa.
Stefano Mancuso invoca un diritto radicale in quanto radicato su questo pianeta, una giustizia che riscopra il proprio debito con la nazione delle piante e ne divenga alleata, cessando la sua storica e parassitaria indifferenza che rischia di distruggere il pianeta della vita.
Lucia Bezzetto