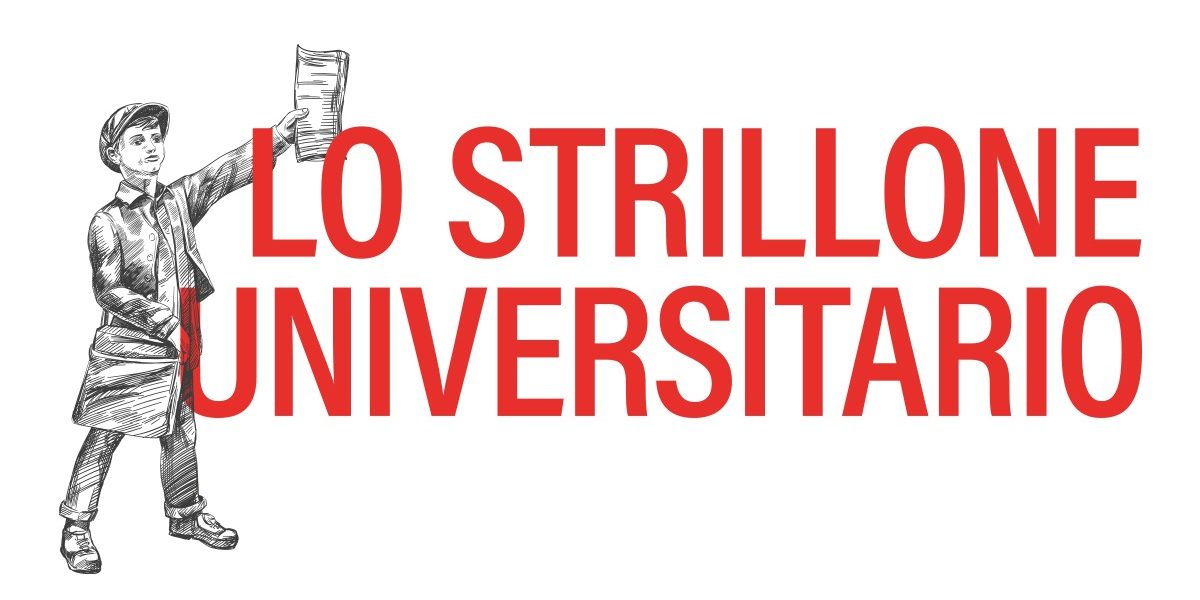Il dogma della vittoria mediocre
Nella società contemporanea si è innalzato lassù nel cielo, insidiandosi quaggiù nel cuore delle menti, il dogma del successo mediocre. Questo comandamento fintamente divino, profondamente artificiale, ci impone una sola e unica cosa: vincere facilmente, senza eroismo! E noi qui, inginocchiati nella sua adulazione, ci siamo trasformati in predicatori di questo fallace verbo, in esecutori di questa menzogna celeste, ricoperta di nuvole. Siamo gli autori e le vittime di questa nuova religione, che nasconde dietro l’apparenza l’eroismo del trionfo, per propugnarci una sua semplificazione pericolosa, mediocre, in grado di trasformare ciò che è assolutamente umano, ossia il successo, in qualcosa di assolutamente estraneo all’uomo, posto all’esterno della sua esperienza, reificandolo in materia senz’anima.
Questa narrazione trascura l’importanza del percorso e dei mezzi utilizzati per l’arrampicata verso la cima, puntando la sua ideale telecamera unicamente verso la luce in fondo alla strada, verso il premio posto sul piedistallo. Si ammettono, infatti, scorrettezze, viltà, mediocrità nascosta dietro la maschera apparente del grande uomo, scorciatoie e successi immeritati, rubati dal destino ai migliori che vengono sconfitti, relegati nell’ombra dalla sfortuna, ingabbiati in un giudizio carcerario che li distorce in ciò che non sono. Importa il fine, non il mezzo; importa solo vincere e non perdere, mentre tutto il resto, tutto ciò che precede questi eventi, è ininfluente. Chi perde scivola via dalla gloria, subito, immediatamente, precipitando nel burrone dell’inferno, in cui regna incontrastato, tra le tenebre dell’oblio, l’ideale diavolo di questa falsa religione, il Fallimento. Il Perdere, così, diventa il nostro più grande peccato, perché rappresenta il completo ribaltamento, la nemesi e l’opposto del dogma che costantemente ci ripetiamo.
Crolla così il romanticismo eroico, che vede nella lotta a testa alta, faccia a faccia, guadagnata col sudore dell’impegno, il massimo raggiungimento per un uomo, indipendentemente da ciò che effettivamente egli riesce a raccogliere dal sudore versato. A questa forgiante visione si sostituisce un utilitarismo privo di scrupoli che tende unicamente a quel valore posto gerarchicamente in alto, oltre cui non vi sono alternative se non la depressione, posta in basso, del cadere nella perdita. Muore quel bellissimo e antico ideale di titanismo, che osserva nel fallimento seguito alla proiezione agonistica di una battaglia per una giusta causa contro un ostacolo troppo grande da scavalcare, il più alto obbiettivo a cui l’uomo può ambire, per avvicinarsi di un soffio al divino nell’esemplarità di coloro che si stagliano dalla massa. Si dissolve nell’aria quell’ideale di morte gloriosa in battaglia, antico come la storia, simbolo di redenzione esistenziale per coloro che lottano per ciò che amano. L’importante è trionfare, il resto conta pochissimo. L’importante è non perdere, piuttosto è meglio non partecipare, rifiutare la sfida, annullare le intenzioni della volontà. L’importante è giungere al traguardo, indipendentemente da come si è corso sulla pista.
Si etichettano come pazzi coloro che rischiano, coloro che non calcolano minuziosamente le percentuali di successo, coloro che credono così tanto a qualcosa da essere disposti, perfino, a perdere per essa. Vengono sbeffeggiati coloro che seguono la strada onestamente, passo dopo passo, senza fare taglioni per accorciare il percorso da coloro che sono arrivati prima senza aver compiuto il minimo sforzo, senza essersi realmente impegnati. Più intelligenti, infatti, sono percepiti quegli uomini che o si rassegnano alla finta impossibilità dell’agire per evitare l’ipotesi di cadere, o coloro che ostentano trionfi senza realmente averne mai ottenuti.
Il fallimento è ciò che più spaventa il cuore del singolo, dal momento che egli è inserito in una società in cui si erge egemonico il mito del successo, monoteistico Dio apparente, di cui gli uomini devono rispettare l’unico e dogmatico comandamento: trionfare in modo mediocre, aberrando la sconfitta. Le grandi celebrità, i Vip, le star e i campioni sublimano nella loro carnalità questa trascendente idea per riprodurla in modo goffo ma stupidamente attraente qui su questa nostra terra. Ecco, allora, emergere dalla nullità etica e valoriale personaggi vuoti di senso ma avvolti da finzione, produttori involontari ma colpevoli dell’equazione verbale che descrive la grandezza in termini economici, sensuali o consensuali, come soldi, donne o popolarità. E l’uomo, affamato di esempi da seguire, si aggrappa ai piedi di questi divi divinizzati, ideali eroi da cui prendere ispirazione, perché accecato dalla lucentezza angelica dei loro ciondoli, per imparare come traslare sul proprio destino quell’inesistente successo che crede essere vero e significativo.
Ora, a causa di questo marcio dogma, l’unico motivo che spinge l’uomo a muovere il suo primo passo è il desiderio pulsionale del traguardo. Non si inizia per volontà di iniziare, quindi, ma si comincia il percorso per volontà di concluderlo. È la fine che muove l’inizio, è la conclusione che origina l’introduzione. Questa visione è paradossale, contraddittoria e pericolosa, perché il movente dell’azione, rivolto ciecamente all’esaurimento dell’intenzione stessa, proiettato, dunque, unicamente alla sua morte soddisfacente e non alla sua graduale e passionale attuazione, conduce al trascurare completamente il percorso, che perde qualunque senso in questa marcia a testa bassa verso la meta. La stessa passione, ossia quella metaforica benzina che ci permette di proseguire sulla strada nonostante le difficoltà con il sorriso negli occhi, diventa inutile, senza senso, perché lo stesso ponte di sogno su cui si cammina crolla nelle trame di questo atteggiamento, lasciando in piedi, eretto nella nebbia dell’inafferrabile e dell’effimero, quel successo posto in fondo, reificato nel suo simulacro appariscente.
Vi faccio un esempio: questa ricerca della vittoria, mossa non dalla volontà di percorre la strada, ma di saltare direttamente, usando tutti i mezzi possibili, alla destinazione, è paragonabile a chi inizia un viaggio non per il gusto di esplorare, viaggiare, emozionarsi e impegnarsi nel cammino, ma per ritornare istantaneamente indietro, a casa. La fenomenologia del trionfo, si comprende, viene soffocata da questa smania irrazionale di distruggere le tappe, azzerando l’importanza dell’impegno capace di dare senso all’esistenza, e innestando nella mente collettiva quel ribaltamento della morale che, ora, attribuisce la gloria alla conclusione della lotta e non alla lotta stessa. È come se Ulisse fosse stato immortalato nella leggenda del ricordo per essere riuscito a ritornare, semplicemente, ad Itaca, sorvolando sull’incredibile e titanica avventura che ha compiuto nel Mediterraneo, ossia proprio su ciò che gli ha permesso di diventare quell’archetipo eroico che noi oggi gli facciamo recitare con le lacrime agli occhi.
Sotto il peso asfissiante di questo dogma, crolla il valore mitologico dell’impegno, visto, ormai, come uno spreco, una stupidata, un gesto inutile nel computo utilitaristico finale. Così, nella nostra contemporaneità tutto ciò che sta in mezzo all’inizio e al traguardo scompare, tutti quei passi che costruiscono gradualmente il percorso, perdono qualsiasi scopo, diventando invisibili nell’attenzione di chi osserva. Ciò che prima era la trama della leggenda, ora diventa una lunghissima parentesi tra prefazione e conclusione, da saltare, troppo faticosa da analizzare, troppo difficile da scrivere, per cui più corta e semplice è, meglio figura al lettore che degusta e vive in modo distratto e infantile l’opera. Peripezie, perdite, sconfitte, fallimenti, cadute, sollevamenti, resilienza, resa e costanza diventano note a pie di pagina, parole ormai sconosciute e odiate dai lettori che non sanno comprenderne il significato.
Simone Rosi