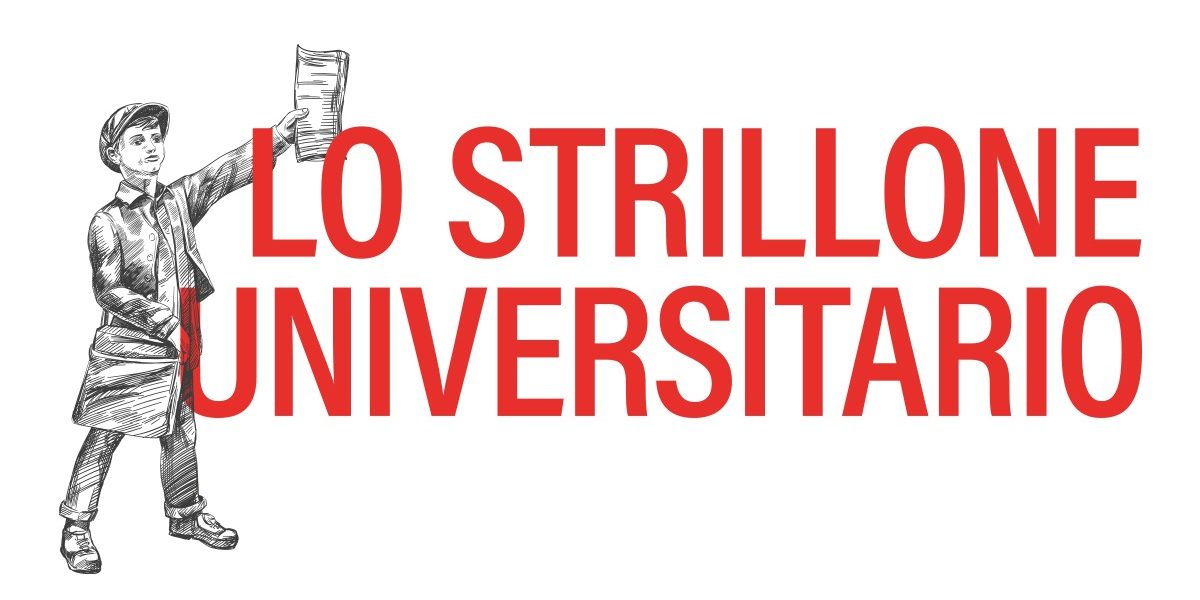L’amore verso gli ultimi che ambiscono ad essere primi
Vi siete mai accorti che, in situazioni in cui la nostra attenzione è neutrale, slegata da qualsiasi finalità o da qualsiasi passione pregressa, noi tifiamo, quasi involontariamente, per i deboli? Pensateci, quante volte si tifa per coloro in svantaggio? Quante volte la nostra attenzione sentimentale è rivolta a coloro privi di talento, di forza e di grandezza naturale, che, nonostante queste congenite mancanze, cercano in tutti i modi, impegnandosi più di ogni altro, ad ovviare con il sudore e con la costanza che distrugge, come una goccia continua, piano piano la roccia, alla loro inferiorità per ottenere quella vittoria non pronosticabile? Questo spiega del perché, durante le ultime edizioni dei mondiali di calcio, per esempio, ci si sia sollevati in piedi, come un corpo unico mosso dal medesimo sentimento, con i cuori aperti alla meraviglia e le menti attente al miracolo, per osservare all’unisono con una trepidazione degna solo per i grandi dei eroi, l’Islanda e i suoi atleti, una nazionale così distante da noi geograficamente e culturalmente, ma così vicina alle nostre anime per quella umana debolezza, travolgente di potenza. E questo discorso, generalizzando, si applica ad ogni disciplina, ad ogni individuo e ad ogni storia in cui si narra con i fatti l’ascesa dell’ultimo o degli ultimi dal fondo alla luce, per cui noi proviamo un’attrazione animalesca, data dal riconoscimento del nostro essere in quei riflessi di piccolezza che ambiscono all’immenso, senza poterlo mai raggiungere, ma senza volerlo nemmeno mai abbandonare nei sogni in cui si tende ad esso.
Cosa c’è di bello in questi piccoli e mediocri Ulisse, alla ricerca di un’Itaca inesistente, quando dall’altro lato del campo si potrebbe contemplare la perfezione di assoluti campioni, forti e senza macchia, entità predisposte al dominio fin dalla nascita? Perché avviene questo? Perché i deboli sognanti hanno connaturato un aspetto romantico di imperfezione, di frattura corrotta in mezzo alla bellezza, di imprevedibile nello scontato, in grado di generare amore come solo ciò che è oscuro di mistero può realizzare. La loro impossibilità di riuscita nella missione ci sprona ad osservarli, senza capire, con l’intento di ricercare quel frammento temporale di distruzione delle possibilità massime che gli attribuiamo, dei limiti che gli imponiamo, come catene soffocanti e alienanti, da cui loro cercano di liberarsi con tutta la volontà che risiede in quella piccolezza assoluta, infinita, umana. Come le formiche, esseri minuscoli, deboli in confronto agli altri, ci sorprendono nel loro trasporto titanico di pesi enormi, in grado di schiacciarle, in salita, in una scalata meravigliosamente umile, allo stesso modo i deboli ci stupiscono nell’esternazione di una potenza che non sembra appartenergli, che non sembra essere loro. E, in quel momento di inaspettata magnificenza, in quella scintilla di onnipotenza scaturita da un essere infinitamente debole, come si fa a tifare per coloro che già sono perfetti e non per coloro che, come un fuoco d’artificio in mezzo alle stelle, oscurano di luce zampillante e scompigliata quei pianeti luminosi e altissimi? Come si fa a voltare gli occhi di fronte a questo spettacolo umano, semplice nella sua umiltà che non pretende l’Olimpo, ma che con la sua esuberanza di sforzo, involontaria e senza cupidigia, sa spaventare perfino le divinità che siedono sui loro immobili troni? Il debole che lotta è un’immensità che illumina il pubblico, stordendo la ragione per la sua incredulità che si realizza nell’atto impuro, scomposto, sofferente, ma enormemente eroico nel suo slancio finito, destinato a concludersi nell’assenza d’energia, nell’annaspante tentativo di non crollare, privo di eleganza ma denso di concretezza, proiettato verso l’infinito. L’osservazione di questo volo senza ali ipnotizza chi scruta il cielo ancora di più della danza aerea senza errori di un’aquila, perché ci insegna che per staccarsi dalla consuetudine e dalla terra che omologa, non serve essere un angelo.
Amiamo i deboli perché ci ricordano noi stessi. Li amiamo perché in loro osserviamo la nostra stessa intimità, la nostra stessa volontà e la nostra stessa minuscola grandezza, debole come una formica, infinitamente potente nell’ambizione più di un essere perfetto. La loro bellezza contagia il mondo, perché solo il bagliore in mezzo al vuoto di luce attrae come nient’altro lo sguardo del cuore. Nelle pieghe di queste umili epiche, di queste basse leggende, noi ci sentiamo coinvolti nella breve trama, perché consapevoli che potremmo sostituirci all’eroe di turno del racconto, a quel debole che è un riflesso realizzato di noi stessi. L’imperfezione che ambisce al perfetto ci rammenta quell’infantile, immatura e inconsapevole idiozia umana che ricerca sempre ciò che non può essere ottenuto, ciò che necessita di sacrificio per vedersi attuato, ciò che pretende sforzo per dare soddisfazione. Questa sconnessa tensione verticale, questa disgiunta energia sentimentale, continua, però, nel suo travolgente flusso, si staglia nel cielo, come raggio solare che buca le nuvole cieche, per rivelarci quel passaggio di possibile in mezzo all’irrealizzabile, imboccabile da tutti, purché disposti a scavare in mezzo al grigiore nebuloso per produrre il proprio squarcio lucente. Essi, come noi, partono dalla mediocrità, dal nostro stesso livello, dalla bassezza che accomuna l’umanità e che lega la massa in un’informe ammasso confuso, privo di identità. Loro, però, nonostante la mancanza di straordinarietà, riescono ad emergere senza averne un naturale diritto, per ergersi come modelli carnali da seguire, slegati dal dogmatismo, dall’idolatria che impedisce l’emulazione, dalla venerazione che inibisce una reale azione. I deboli, infatti, a differenza degli olimpici abitanti o del paradisiaco sovrano, sono divinità con anima, sentimenti e difetti che ci consentono di osservarli, senza volerlo, nella loro fenomenologia, identificabile come una supernova, stupefacente nell’esplosione e destinata a spegnersi nell’esaurimento della volontà, non per essere glorificati, quanto per diventare un’ispirazione dell’agire. Sono un Noi migliore, un’identificazione esterna, resasi materiale, concreta e vera della nostra volontà che non è riuscita ad esprimersi nell’atto. Sono ciò che vorremmo essere, sono ciò che la nostra forza non è riuscita a diventare.
Il Saggio dello sport, Simone Rosi