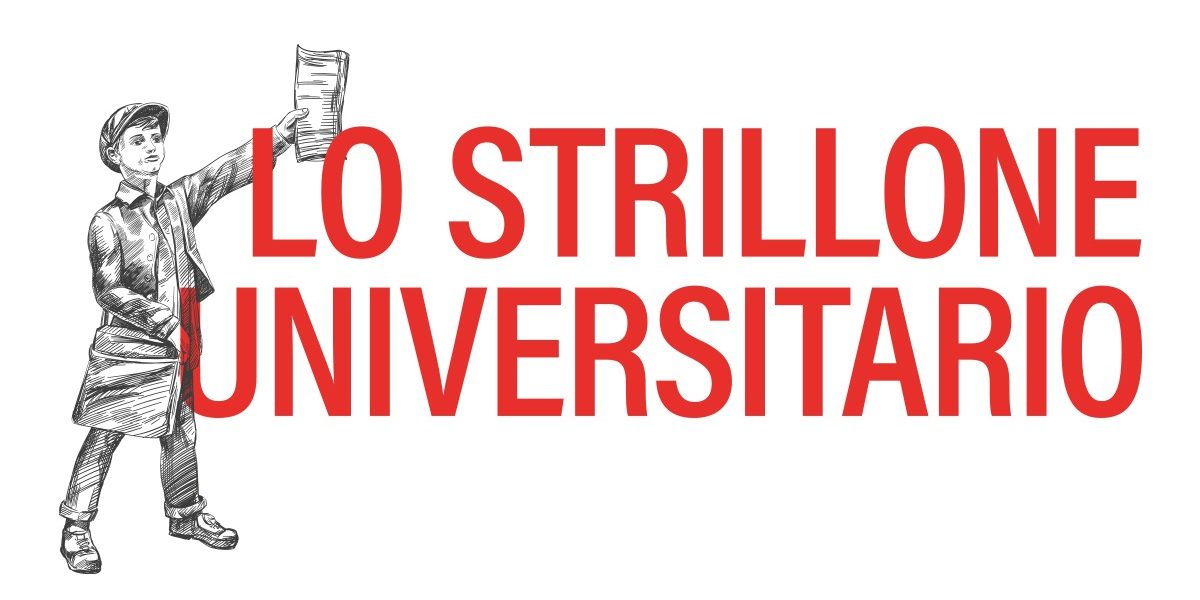Nell’immaginario collettivo i “boss” malavitosi sono sempre identificati con personaggi di una certa età, magari con una lunga carriera criminale alle spalle e altrettanti anni da passare all’interno delle patrie galere. Solitamente ci adagiamo su un’iconografia che rasenta il simbolismo più stereotipato. Talora li identifichiamo con coppola e lupara sulla falsariga dei personaggi presenti nel film “Il Padrino-prima parte”, altre volte agli uomini d’affari in doppiopetto il cui aspetto inoffensivo viene smentito da un sigaro o da un seguito di balordi al loro fianco. Confondiamo spesso gli attori protagonisti delle rappresentazioni cinematografiche al mafioso presente nella realtà. Ovviamente la realtà è molto diversa.
Nessuno identifica mai un ragazzo adolescente come capo di un’organizzazione criminale. Reclutare giovani non ancora maggiorenni comporta per la malavita enormi vantaggi, non solo economici. Si trovano a dover istruire nuove reclute per esclusivi fini legati al benessere dell’organizzazione e dei loro membri. Principalmente i giovani vengono inseriti nel mercato dello spaccio di droga, ma possono anche occuparsi di riscossione di tangenti, intimidazioni, detenzione armi, gambizzazioni e delitti su commissione.
Insomma i giovani sono un’arma vincente e la mafia ha costruito con loro un legame molto forte.
Cosa spinge questi ragazzi ad idealizzare un vita piena di paure, pistole e tradimenti? La domanda sorge spontanea così come la risposta: soldi, potere, notorietà, reputazione. Giovani spesso cresciuti in ambienti che hanno favorito la loro dedizione a questo stile di vita e che hanno come principale modello di successo la vita dei “vecchi boss”. I bambini infatti istruiti dalle famiglie mafiose hanno spesso l’unica via del crimine. A 7 anni si impara a sparare, c’è chi vuole essere già affiliato e chi inconsapevolmente è già un corriere della droga. A 16 si controllano le piazze di spaccio e si muore nelle faide.
Nel 2017 l’associazione daSud ha creato un dossier curato dai giornalisti Danilo Chirico e Marco Carta e intitolato “Under- Giovani, mafie, periferie” in cui si ripercorre dal Mezzogiorno al Sud Italia, le storie ed i numeri legati ai giovani boss. Storie e numeri che lasciano a bocca aperta per la quantità di giovani che intraprendono questa vita. Nel 2016 i giovani under 18 denunciati per reati legati agli stupefacenti arriva a 5.123. 3mila in più rispetto agli anni 90.
Sono tantissimi gli esempi che potremmo riportare, forse troppi. Come Emanuele, il giovane boss camorrista definito leader indiscusso della “paranza dei bambini” ucciso a Napoli da una banda rivale in sella alla sua moto a soli 19 anni. Ma ci sono anche ragazzi che non hanno alcun legame di parentela con i membri delle organizzazioni. Il dossier racconta anche di Antonio (anche se non è il vero nome), figlio di un operaio e di una casalinga, che già a vent’anni risultava affiliato e che oggi, a ventisei anni e con una laurea in mano, maneggia i soldi falsi della ‘ndragheta.
Proprio in Calabria però negli ultimi anni ci sono state madri che hanno deciso di portare via i figli da questo mondo. Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha così dato vita al protocollo “Liberi di scegliere”, intraprendendo la via per togliere la patria potestà ai genitori affiliati alla ‘ndrangheta.
Non mancano purtroppo storie senza un lieto fine, come quella di Maria Concetta Cacciola indotta al suicidio dalla famiglia proprio per aver cercato di allontanare i tre figli dalla cultura mafiosa.
Da nord a sud i giovani diventano la forza necessaria alle mafie per puntare sempre più in alto.
Prendiamo Napoli. A Napoli le nuove generazioni di camorristi si uccidono nei rioni, in mezzo alle piazze, negli stessi quartieri che si sono divisi e che considerano esclusivamente una fonte di guadagno. Sono ragazzi senza controllo che spettacolarizzano la loro appartenenza al clan anche all’interno dei social network.
In Sicilia i giovani boss sono da primato nazionale. Iniziano piccolissimi, dai dieci o tredici anni.
Gli uomini delle cosche siciliane infatti, selezionano i minori più violenti e capaci e li pongono sotto la protezione di un padrino. Inizia così il loro periodo di apprendistato che si conclude con l’iniziazione vera e propria. Questa prevede però delle sfide da superare. In genere, i giovani scelti devono appiccare incendi o compiere altre forme di intimidazione. Il livello superiore è invece raggiunto con il coinvolgimento nelle estorsioni. In questi casi il maggiorenne si reca dai soggetti da ricattare accompagnato dai minori, in modo da fare comprendere alla vittima che saranno questi ultimi a riscuotere le rate del pizzo.
Quello dei “Baby boss” è quindi un fenomeno presente in tutta Italia. Non solo Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia e in Lazio non mancano i giovani ammazzati in nome di un ideale così sciagurato e incomprensibile.
Come dei moderni cavalieri templari, sono convinti di appartenere ad una società che rappresenta il bene più alto: quello dell’odio e dell’egoismo. Sono convinti che perdere la vita a sedici, diciannove o ventidue anni faccia di loro degli eroi da ricordare per le generazioni future. I baby boss sono giovani diversi da noi. Hanno aspirazioni diverse, vite diverse. Non sono bambini che sognano di fare l’astronauta o il medico o il veterinario. No, da grande voglio fare il boss.
Una vecchia citazione di Gesualdo Bufalino, scrittore e poeta siciliano, recita: «la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari», ed io la fine la immagino proprio così.